Invecchiamento e Senescenza
L’invecchiamento è il processo fisiologico di trasformazione fisica e chimica di un organismo per effetto del tempo, accompagnato da una diminuzione o perdita di funzionalità (Holiday, 1998; Arking, 1998; AA. VV., 1994).
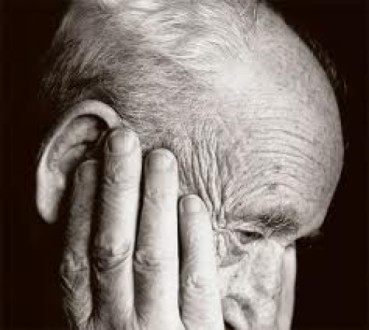 Circa 2000 anni fa, la durata media della vita degli esseri umani era 22 anni, attorno all’anno Mille salì a 33 anni e all’inizio del XX secolo, nei paesi industrializzati, raggiungeva i 50 anni. In seguito essa è rapidamente aumentata e nel 1980 era, in Europa e negli U.S.A. , di circa 75 anni. Tale netto incremento è dovuto principalmente al miglioramento delle condizioni di vita che hanno progressivamente garantito una più efficace protezione contro agenti patogeni o altri fattori di morte.
Circa 2000 anni fa, la durata media della vita degli esseri umani era 22 anni, attorno all’anno Mille salì a 33 anni e all’inizio del XX secolo, nei paesi industrializzati, raggiungeva i 50 anni. In seguito essa è rapidamente aumentata e nel 1980 era, in Europa e negli U.S.A. , di circa 75 anni. Tale netto incremento è dovuto principalmente al miglioramento delle condizioni di vita che hanno progressivamente garantito una più efficace protezione contro agenti patogeni o altri fattori di morte.
Al contrario, la durata massima della vita è restata più o meno immutata nel tempo: nel passato come oggi, gli individui più longevi raggiungono circa i cent’anni di età. La durata media della vita presenta nella nostra specie una chiara differenza sessuale: l’aspettativa di vita di una donna di 65 anni è di 19 anni mentre per un uomo sarebbe di soli 13 anni.
Sebbene le ragioni della maggiore durata della vita negli individui di sesso femminile siano attualmente ignote, è stato ipotizzato che intervengano sia fattori biologici, come l’azione protettiva degli estrogeni, sia fattori socio-economici. L’invecchiamento è associato a segni di alterazione sia strutturale sia funzionale sia negli animali che nelle piante.
Nella sfera animale alcuni esempi sono i capelli e i peli bianchi, le rughe e le macchie sulla pelle, l’incurvamento della colonna vertebrale, la diminuzione del volume muscolare, la progressiva riduzione delle capacità sensoriali, diminuzione del desiderio e dell’attività sessuale.
Riguardo alle piante questi segni possono essere osservati in un calo dell’attività fotosintetica, nella secchezza dei rami e delle foglie con una diminuzione nell’afflusso di linfa grezza ed elaborata. Benché tali segni caratterizzino la maggior parte delle fasi di invecchiamento, non tutti possono essere utilizzati nel definire rigorosamente tale processo, infatti, è essenziale distinguere gli effetti dovuti a motivi fisiologici da quelli dovuti ad eventi patologici. In questo articolo ci interesseremo degli effetti fisiologici che propriamente riguardano la senescenza naturale di tutti gli esseri viventi. Approfondimenti riguardanti la senescenza nelle piante sono stati pubblicati nella mia tesi (Miglietta, 2006).
Quali possono essere le cause che sono alla base dell’instaurarsi dei processi d’invecchiamento?
Possiamo definire un verso di percorrenza univoco che stabilisca se è possibile arrestare o far regredire questo progressivo deperimento della materia vivente?
Negli ultimi decenni, sono state avanzate numerose teorie sulle possibili cause dello sviluppo dei tratti caratteristici della senescenza (Holliday, 1998; Bengtson e Schaie,1999).
Le diverse teorie proposte possono essere riunite in due gruppi principali, ciascuno incentrato su uno specifico concetto di base:
(A) programmazione genetica dell’invecchiamento;
(B) processo di deterioramento progressivo prodotto da fattori sia esogeni sia endogeni che riduce l’efficienza metabolica della cellula fino a portarla alla morte.
Recentemente è stata proposta anche una teoria cosiddetta «unificatrice» che considera l’influenza sia di fattori genetici sia di quelli ambientali e di deterioramento progressivo.
Il gruppo A riguarda naturalmente l’apoptosi nota anche con la sigla PCD (Programmed Cell Death). Si tratta di un processo geneticamente controllato, necessario per il corretto sviluppo degli organismi pluricellulari.
Nelle piante questa forma ordinata di morte cellulare caratterizza numerosi processi legati allo sviluppo come l’embriogenesi, la differenziazione e la senescenza fogliare, lo sviluppo dell’aerenchima e dello xilema. La PCD è caratterizzata da una varietà di fenomeni biochimici e molecolari e da una serie precisa di cambiamenti morfologici che vengono definiti “PCD hallmarks”. Tali cambiamenti includono la condensazione del nucleo, il restringimento del citoplasma, la frammentazione del DNA e l’attivazione di specifiche proteasi (Spano, 2001).
Per meglio comprendere le implicazioni legate alle teorie del gruppo B dobbiamo rifarci al concetto di “adattamento”. Non esiste una precisa ed univoca definizione di che cosa sia un adattamento. Con lo stesso termine si indicano fenomeni piuttosto diversi fra loro ma tuttavia traducibili in tre diverse nozioni.
Costituiscono adattamento: il processo che si attua in tutte le specie viventi e che comporta l’aggiustamento complessivo di caratteristiche biochimiche, fisiologiche, morfologiche, comportamentali, ecc. in relazione e in accordo con il contesto abiotico e biotico di vita; il singolo carattere (o meglio la caratteristica: cioè lo stato, tra tutti quelli possibili, in cui il carattere effettivamente si manifesta) che, per esempio, rende un organismo capace di utilizzare una determinata risorsa e che viene mantenuto dato che in quel contesto fornisce un vantaggio all’organismo che lo porta; ma è adattamento anche il possesso di complessi strutturali macroscopici, morfo-funzionali, filogeneticamente ricevuti ed espressi alla scala macroevolutiva che corrispondono all’occupazione di intere «zone adattative» e garantiscono lo svolgimento di funzioni di livello gerarchico molto elevato.
Si tratta, per intendersi, dei complessi morfo-funzionali cui ci riferiamo quando parliamo di «adattamento al volo» o di «adattamenti all’ambiente subaereo» riferendoci agli animali, ma adattabili anche ai vegetali basti pensare all’«adattamento alla vita di sottobosco o in ambienti palustri ad elevate concentrazioni saline».
La suddivisione e diversificazione delle proprie nicchie vitali garantisce agli esseri viventi sopravvivenza ed è di fatto un “assoggettarsi” all’ambiente di residenza. Pertanto quando l’adattamento non è possibile perché le condizioni ambientali variano (stress) in modo repentino o in un range di valori troppo grande rispetto a quello tollerato (eccesso di sali, siccità, troppa luce o troppo poca, competizione interspecifica ecc.) è lecito iniziare a parlare di deperimento cellulare.
Negli animali, una fonte di stress da non sottovalutare è fornita da una alimentazione sregolata, da una alterazione del ciclo sonno veglia, ma non solo. La definizione del termine risale al fisiologo Hans Selye, che per primo si interessò all’argomento, nella trattazione della cosiddetta «sindrome generale di adattamento». Lo stress, nella visione di Selye, è essenzialmente un perturbamento dell’equilibrio omeostatico dell’organismo, suscitato da un qualsiasi fattore esterno o interno. Nell’uso comune il termine stress ha assunto una accezione negativa. In realtà esso è necessario ai diversi individui, che, attraverso queste risposte fisiologiche e comportamentali ristabiliscono una situazione di equilibrio, indispensabile alla salute e talora alla sopravvivenza stessa del soggetto.
Nella senescenza, per esempio, quando le funzioni vitali dell’organismo mostrano un generale declino, si riscontra una minore capacità di mantenere l’omeostasi. Esperimenti condotti su ratti di laboratorio hanno permesso di dimostrare una minore efficienza nel feedback negativo, cioè nella capacità di terminare la risposta allo stress, negli animali più anziani, se paragonati a quelli più giovani. In ogni caso, a prescindere dalle differenze interindividuali, legate ai diversi fattori, tutti gli individui hanno una soglia allo stress, superata la quale si verifica la risposta dell’organismo.
Se questa risposta non è adeguata o se le condizioni di stress si prolungano, le capacità di reazione del soggetto vengono superate, le risorse vengono esaurite e subentrano disturbi somatici gravi, sino ad arrivare alla potenziale morte dell’organismo.
Inoltre possiamo già affermare che esista una differenza tra la senescenza programmata e quella indotta da fattori esterni. In quest’ultima, infatti, si suppone che il processo possa essere bloccato ed invertito a condizione che lo stress venga attenuato prima che sia passato troppo tempo e che i meccanismi metabolici coinvolti non abbiano già instaurato una reazione a catena troppo ampia (Stoddart and Thomas, 1982).
Come abbiamo già accennato all’inizio, alla luce delle conoscenze attuali, l’aspettativa di vita di noi esseri umani è aumentata notevolmente. Se nel Medioevo era di 50-60 anni, oggi si aggira intorno agli 80 e tende a sfiorare i 90.
A raggiungere questo traguardo ha contribuito anche il benessere economico che ha permesso una vita più tranquilla ed una alimentazione più ricca e varia. Elisir di lunga vita non ne esistono ancora, ma, ad esempio, possiamo considerare tali tutti gli alimenti ricchi di antiossidanti ed antiradicali liberi (le vitamine della frutta e verdura sono prodotte dalle piante proprio con questo scopo), o in grado di diminuire i livelli di colesterolo nel nostro sangue (come gli acidi grassi presenti nel pesce azzurro).
Ci si è resi conto che lo stress produce molecole altamente pericolose per l’organismo chiamate “radicali liberi”. Pertanto per vivere a lungo è bene condurre una vita lontana da fonti eccessive di stress pur mantenendo in attività il proprio corpo (passeggiate, ginnastica) e conducendo una sana alimentazione preferendo piccoli pasti divisi nel corso della giornata e ricchi di frutta e verdura, piuttosto che grandi abbuffate limitate ad 1 o 2 volte nel corso delle 24 ore contenenti un eccesso di calorie non richieste per lo stile di vita condotto.
Alcuni antiossidanti, infatti, hanno vita breve e circolano poco nell’organismo; ad esempio la vitamina C viene espulsa dal corpo attraverso le urine molto in fretta. Questo accade perché gli uomini non sono in grado di accumularla in scorte a lungo termine. D’altro canto non bisogna eccedere neanche in questo senso assumendo integratori artificiali che, in grande quantità, potrebbero anche risultare tossici per l’individuo.
Questo articolo è stato pubblicato nella collana Episteme L’Orizzonte degli Eventi edizioni PUBLIGRAFIC, dell’Associazione I Giovani e le Scienze.
---
Bibliografia:
AA.VV., L’invecchiamento. I quaderni de «Le Scienze», G. Vallar ed., Le Scienze S.p.A., Milano 1994;
L. MIGLIETTA Analisi a livello molecolare del processo di senescenza in Triticum Durum, 2006; R. ARKING, Biology of Aging, Sinauer Associates, Inc. 1998;
R. HOLLIDAY, Capire l’invecchiamento, Zichelli, Bologna 1998;
SPANO Physiological and molecular characterisation of “stay green” mutants in durum wheat, 2001; STODDART L, THOMAS H Leaf senescence. In: Encyclopedia of plant physiology, 1982 V. L. Bengston – K.W. Schaie, Handbook of Theories of Aging, SgerPub. Co., New York 1999;
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere

